- Home
- CINEMA
-
VIAGGI
- BRETAGNA E NORMANDIA
- RUNTUR: IN GIRO PER L'ISLANDA >
- IN CANOA E KAYAK SUI LAGHETTI DELLA LOMBARDIA
- SARDEGNA: LE SPIAGGE DELLA GALLURA
- Un po' di PORTO...
- CHEIRA A LISBOA
- LONDRA LOW COST
- VIAGGI OFF LINE >
- GUIDA ALLE SPIAGGE DI CRETA OVEST
- LA COSTA DEGLI ETRUSCHI
- UN'ESTATE FAI-DA-TE A MAURITIUS
- UN SALTO NEL BALTICO: Lituania, Lettonia, Estonia
- TENERIFE NORTE: una guida di viaggio
- LIONE E LA FESTA DELLE LUCI
- IRLANDA SETTENTRIONALE >
- NAPOLI, LA CITTA'-TEATRO >
- Cornovaglia e Inghilterra del sud-ovest >
- ALL YOU CAN INDIA
- VALENCIA
- Wandering into the Wonderland >
- FOTO
- HAPPY HOUR
- CUCINA
-
BLOG NOTES
STORIE RITMI MOVIMENTI - LORENZO MATTOTTI |
AutoreMauro Caron possiede, tra i suoi molti talenti, quello della culturagenerale. Tra gli altri suoi pregi, è superficiale, non sa parlare in pubblico (intendendosi per pubblico assembramenti di persone da una in su) - ecco perché la scelta del blog -, è pigro ed incostante - ecco perché il blog non durerà. Archivi
Aprile 2024
Categorie
Tutti
|
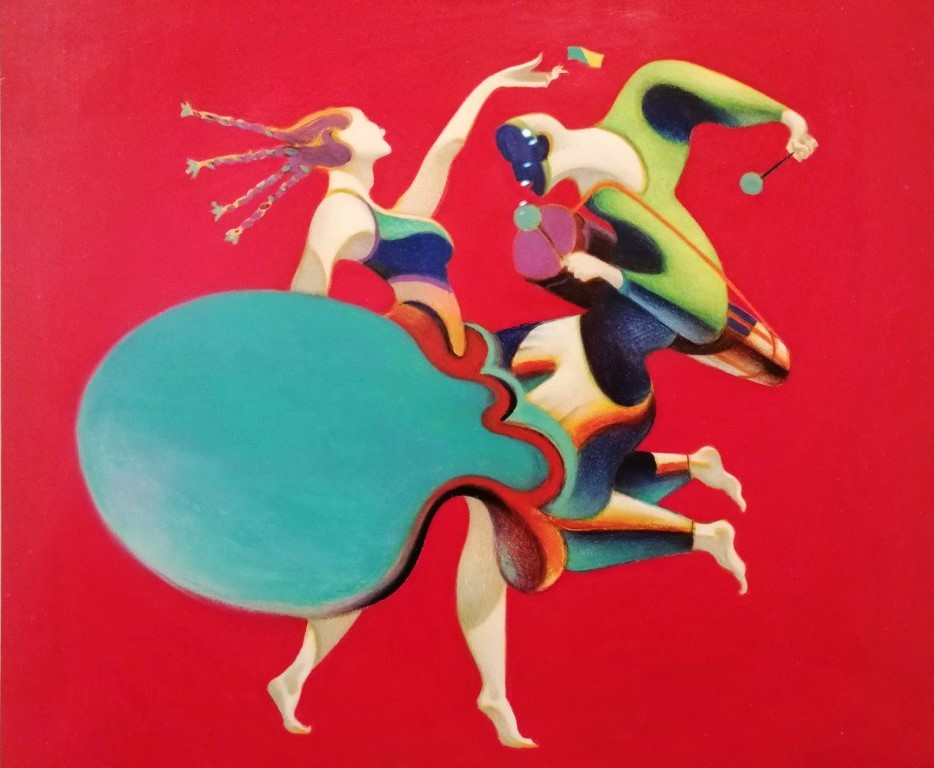
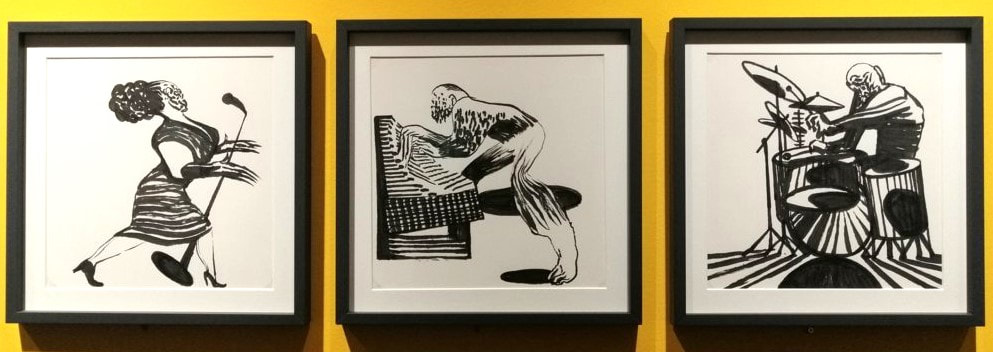
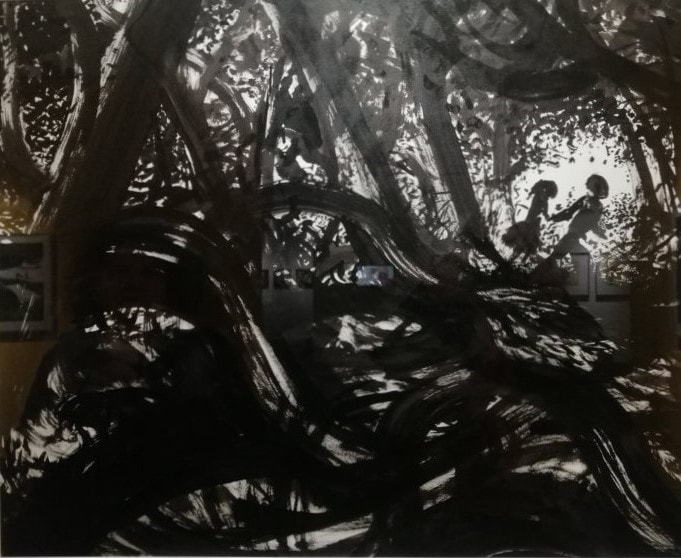

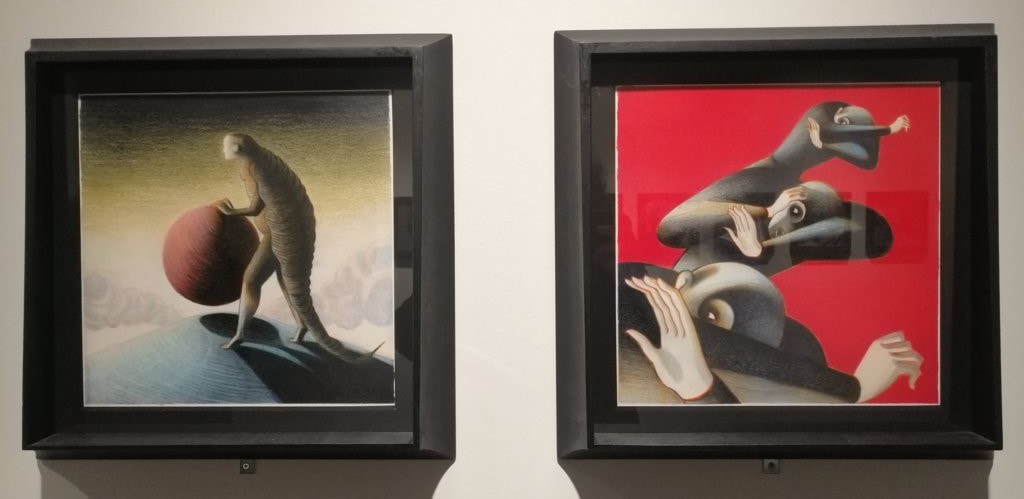
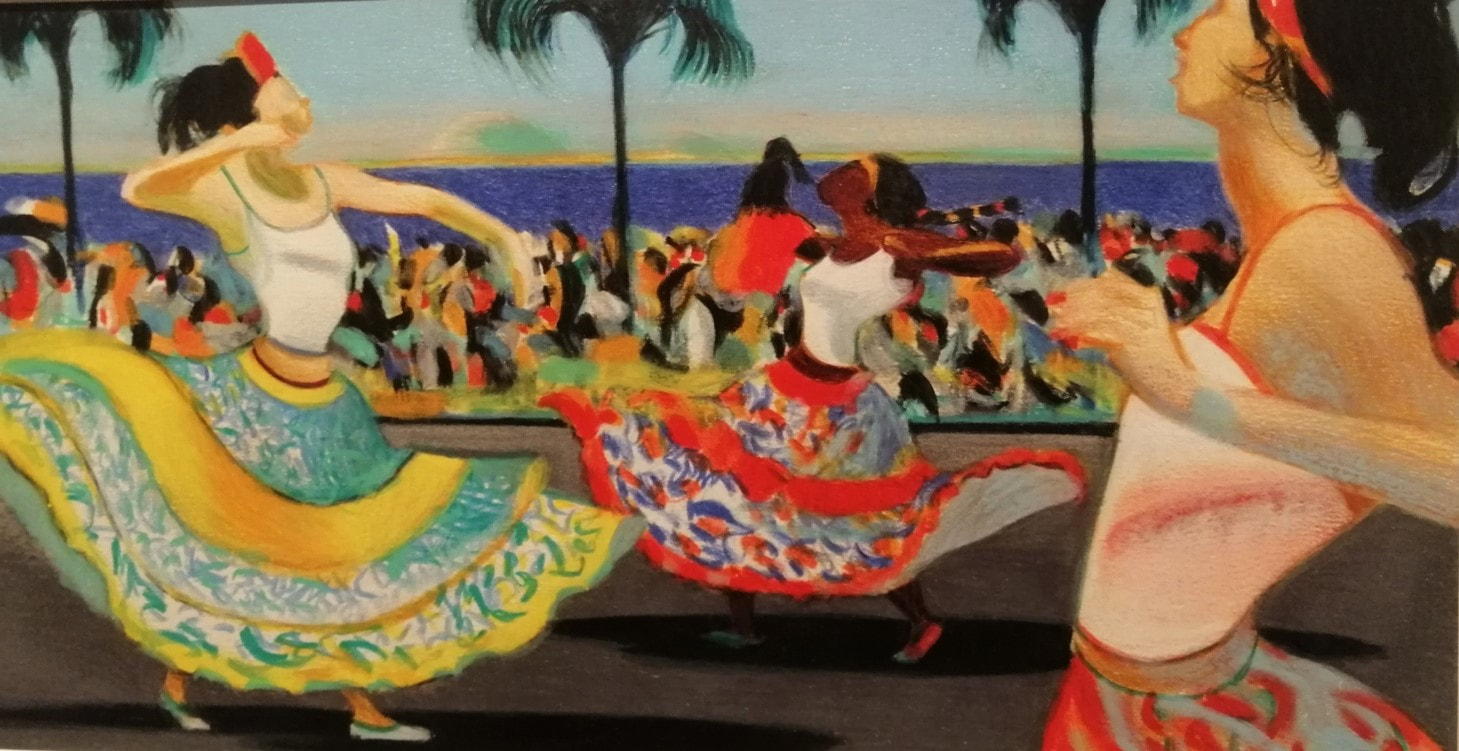

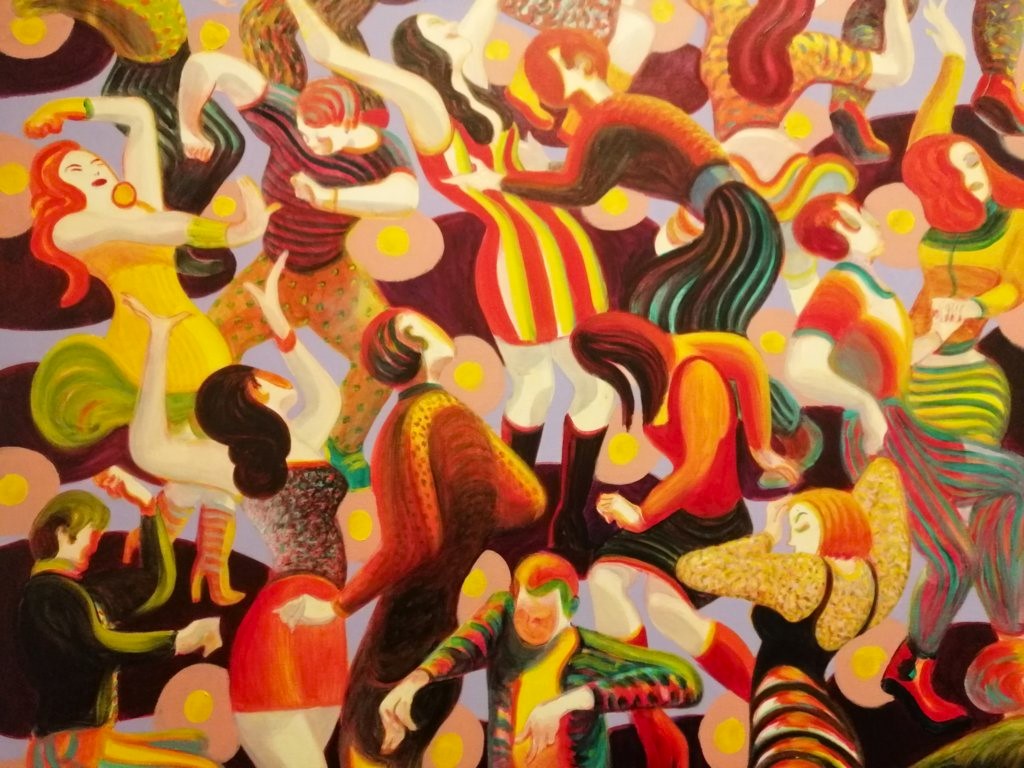





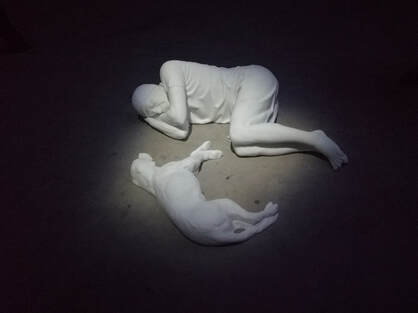




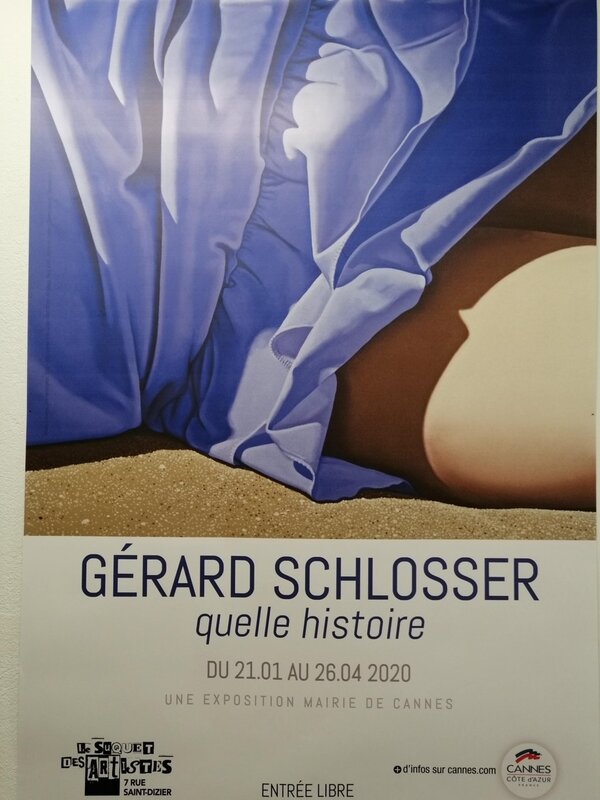
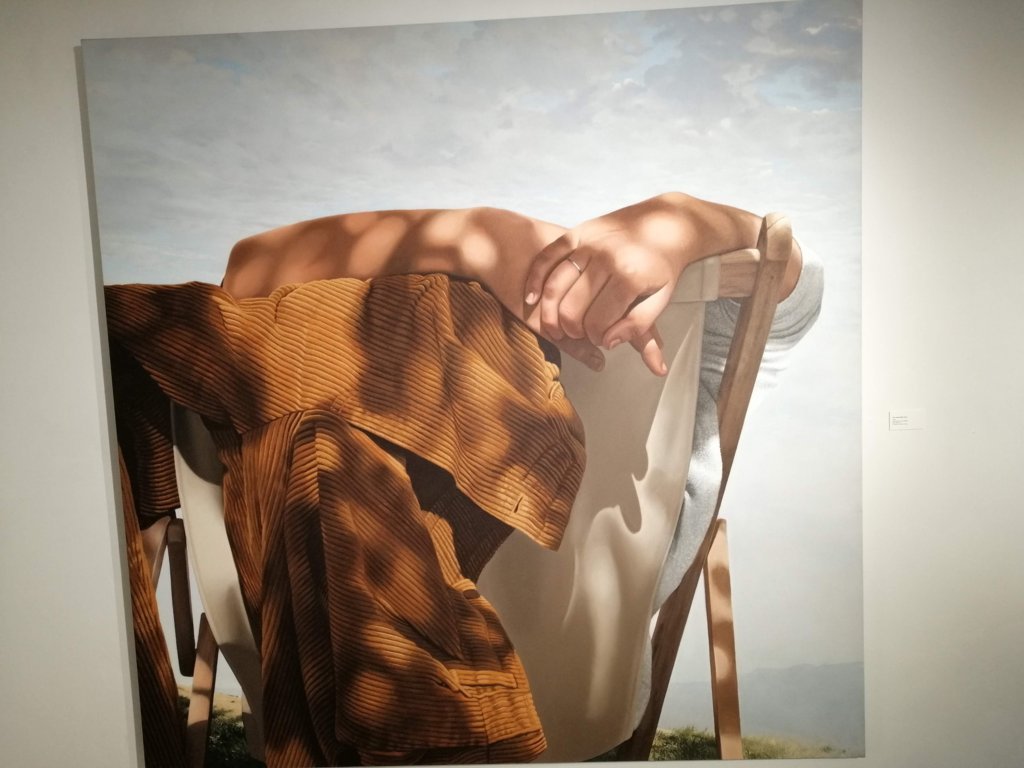
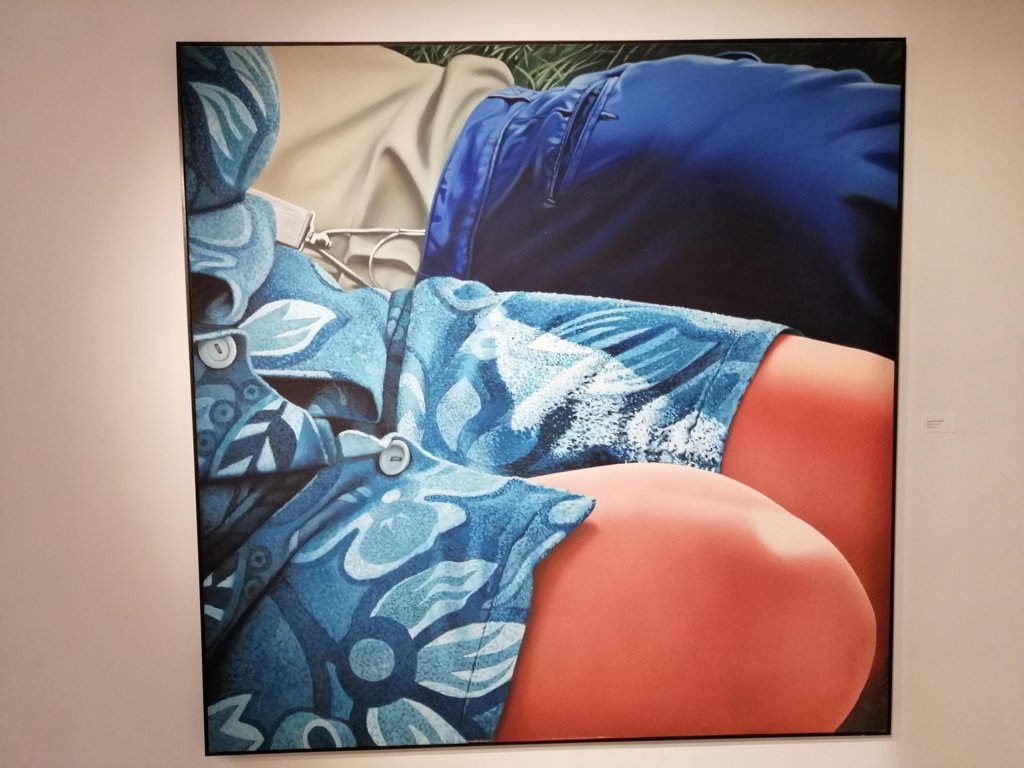
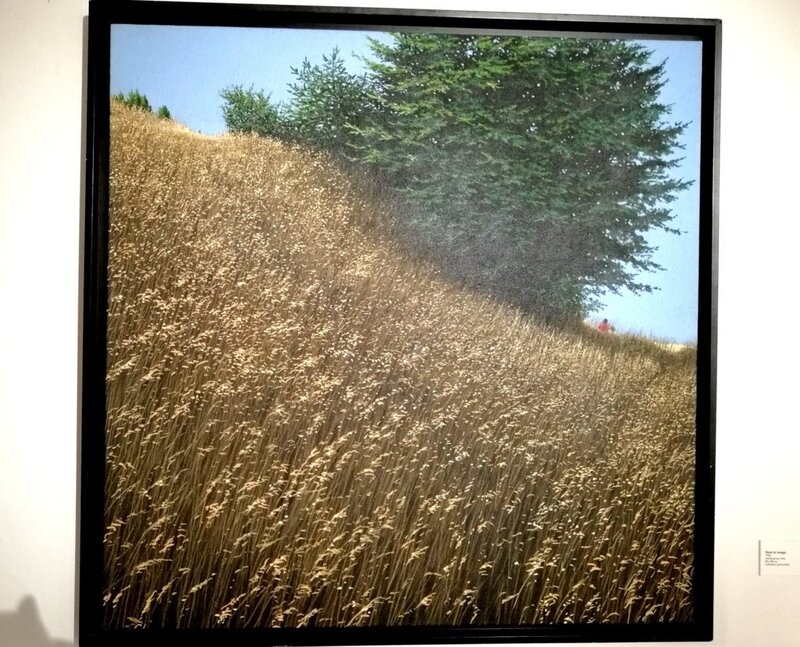
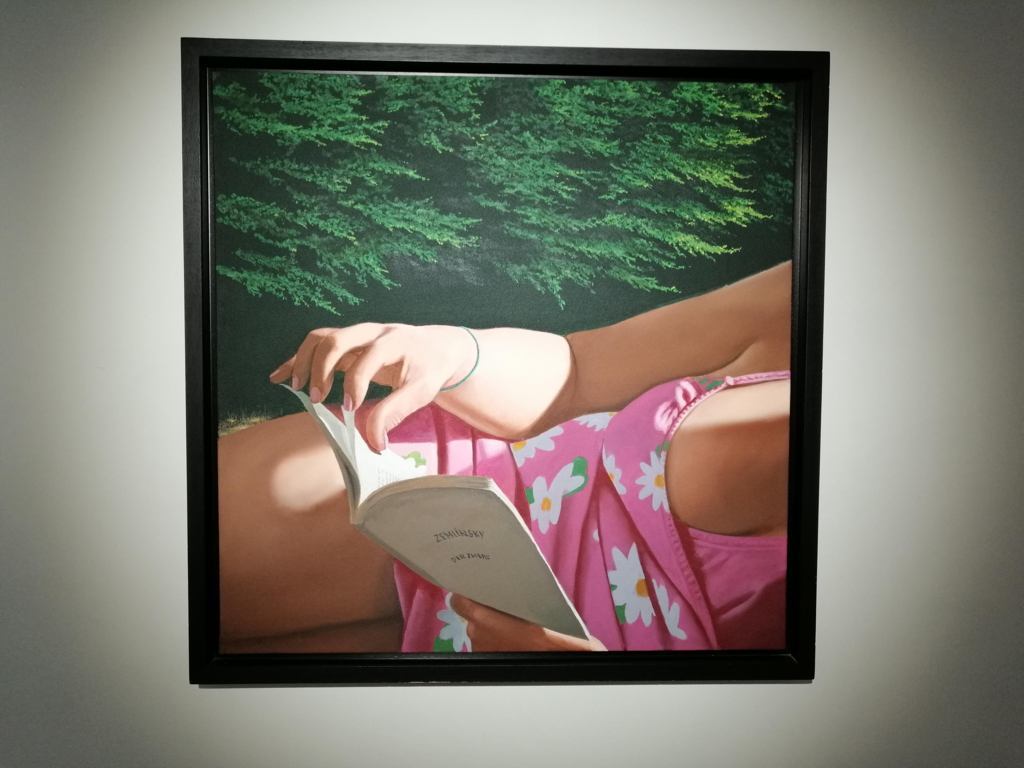
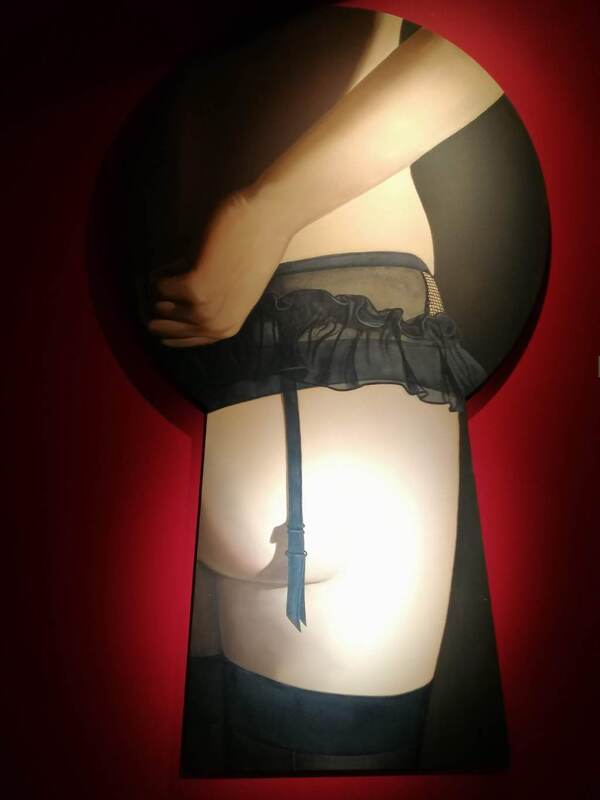




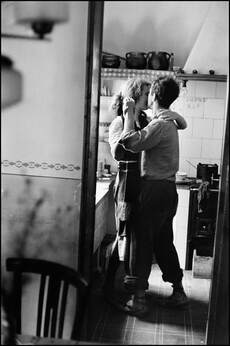








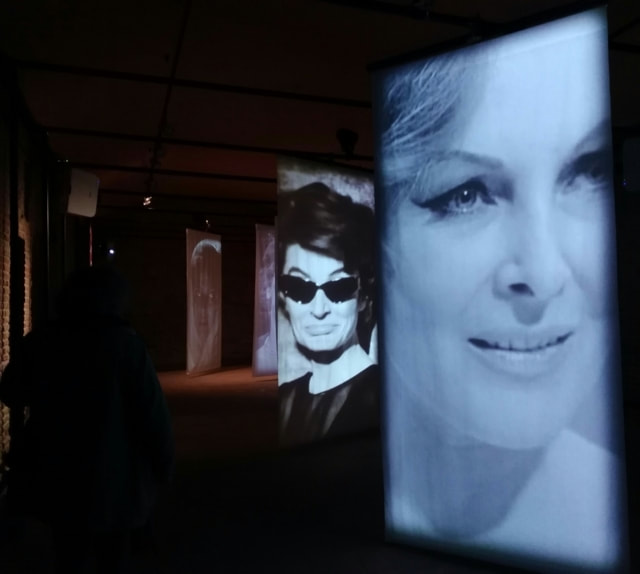



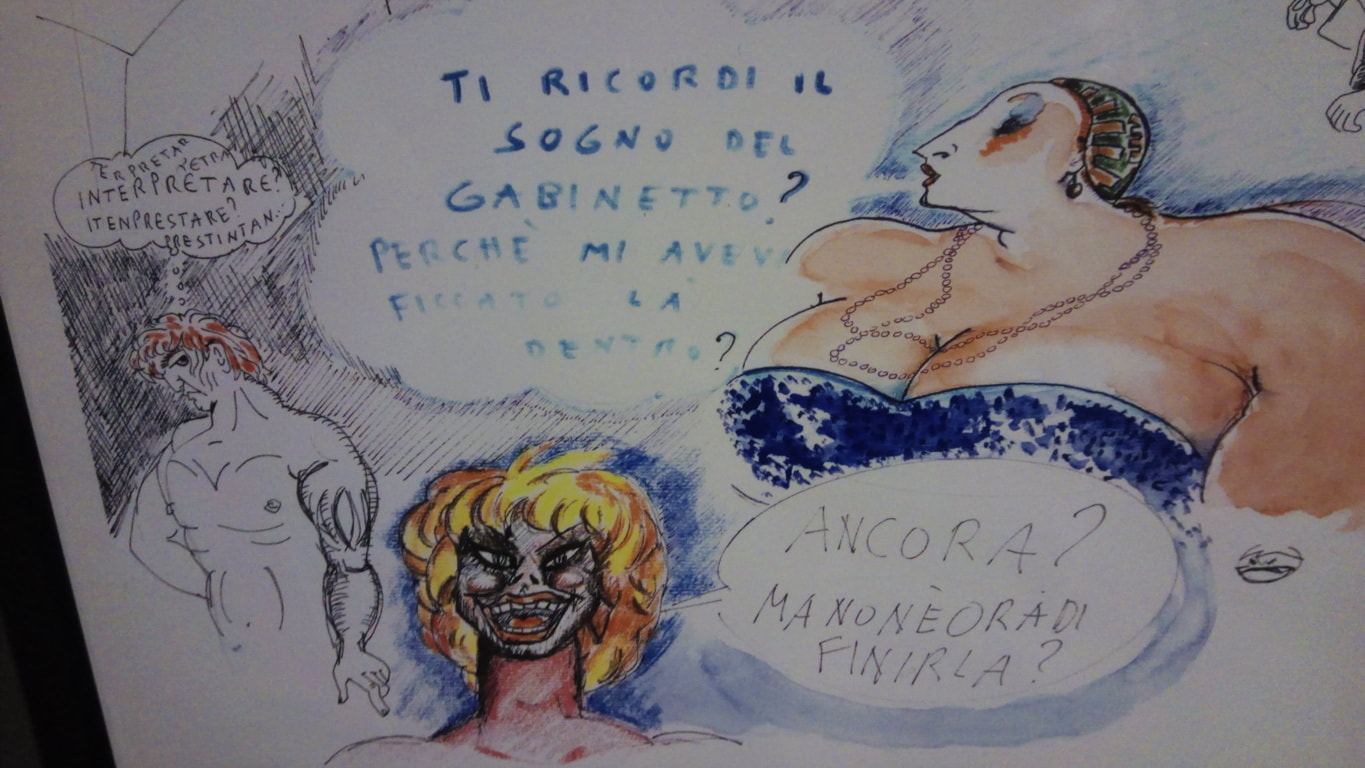













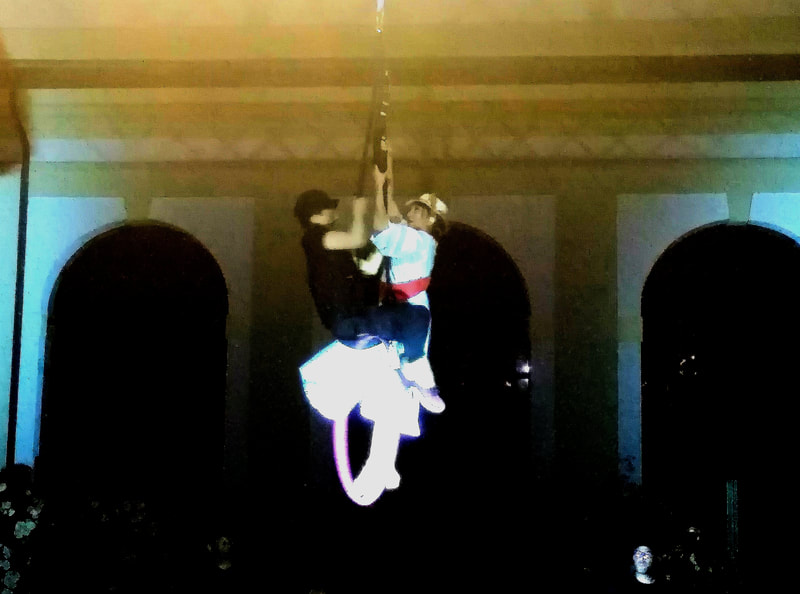





 Feed RSS
Feed RSS
